Vite di persone di scienza: Burton Richter
di Paolo Di Sia
Il 18 Luglio 2018 ci ha lasciati il fisico statunitense Burton Richter, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1976 (assieme a Samuel Chao Chung Ting) per il lavoro pionieristico svolto nella scoperta di un nuovo tipo di particella elementare pesante (ha aiutato a scoprire la prima particella contenente un quark “charm”).
 Richter era nato a Brooklyn, New York, il 22 marzo 1931, e cresciuto nel Queens, un altro quartiere della città. Uscito dal liceo con una forte passione per gli esperimenti scientifici, si iscrisse al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge, dove conseguì la laurea nel 1952 e il dottorato in fisica quattro anni dopo. Si trasferì alla Stanford University e nel 1963 al nuovo Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) in California, dove trascorse il resto della sua carriera. È stato direttore dello SLAC dal 1984 fino al 1999, ed è rimasto coinvolto nella ricerca e nella politica della fisica fino al suo ultimo giorno di vita.
Richter era nato a Brooklyn, New York, il 22 marzo 1931, e cresciuto nel Queens, un altro quartiere della città. Uscito dal liceo con una forte passione per gli esperimenti scientifici, si iscrisse al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge, dove conseguì la laurea nel 1952 e il dottorato in fisica quattro anni dopo. Si trasferì alla Stanford University e nel 1963 al nuovo Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) in California, dove trascorse il resto della sua carriera. È stato direttore dello SLAC dal 1984 fino al 1999, ed è rimasto coinvolto nella ricerca e nella politica della fisica fino al suo ultimo giorno di vita.
I fisici delle particelle generalmente rientrano in una delle tre categorie: (i) teorico, (ii) sperimentale, (iii) fisico degli acceleratori. Ogni categoria richiede competenze molto particolari e specialistiche, pertanto poche persone sono in grado di padroneggiarne più di una. Richter è stata l’eccezione; si è infatti distinto nel progettare e costruire acceleratori, oltre a progettare e condurre esperimenti che li hanno utilizzati.
La particella elementare pesante scoperta si chiama J/ψ. Appartiene alla famiglia dei bosoni, gruppo dei mesoni, è composta da 1 “quark charm” e 1 “antiquark charm”, ha massa pari a 3,0969 GeV/c^2 e vita media di 7,2 × 10^(-21) secondi. Il suo doppio nome è dovuto al fatto che due gruppi sperimentali annunciarono i loro risultati nello stesso giorno: quello condotto da Richter allo SLAC e quello condotto da Samuel Ting al Brookhaven National Laboratory (MIT). Notarono di aver scoperto la stessa particella e annunciarono le loro scoperte l’11 novembre 1974.
L’esplosione dell’attività scientifica iniziata con la scoperta della particella J/ψ nel 1974, è nota ai fisici delle particelle come la “Rivoluzione di Novembre”, perché ha cambiato radicalmente la loro prospettiva. I quark charm, più pesanti dei quark che costituiscono protoni e neutroni, erano predetti dalla teoria che divenne il “modello standard” della fisica delle particelle. La ricerca di particelle che li contenevano ha aperto un nuovo capitolo nella fisica.

Richter ha reso possibile tale rivoluzione progettando e costruendo l’acceleratore di elettroni-positroni SPEAR e un innovativo impianto di rivelazione, entrambi presso lo SLAC. La cosa curiosa è che in realtà egli non stava cercando questa particella. Accettò di lasciare che i suoi colleghi, Marty Breidenbach, Vera Lüth e Roy Schwitters, “sprecassero un weekend” (come disse) per ripetere le misurazioni nella verifica di un’anomalia nei loro dati. Non si trattava invece di un’anomalia, ma di una nuova particella; in pochi mesi, ulteriori scoperte hanno confermato la loro interpretazione della particella come un quark charm.
Questa scoperta non sarebbe però avvenuta senza l’energia e la volontà di Richter. La maggior parte dei fisici non aveva infatti visto lo SPEAR come una priorità, e il Congresso degli Stati Uniti non lo voleva finanziare. Dopo anni di rifiuti, Richter ridisegnò il progetto per ridurre i costi, convincendo il suo direttore di laboratorio e la Commissione per l’Energia Atomica. L’idea fu di rivisitare il progetto come miglioramento di una struttura esistente, piuttosto che come nuovo progetto, e così facendo non ebbe bisogno dell’approvazione del Congresso.
Il suo entusiasmo per gli anelli di accumulazione, dove le particelle circolano per ore, iniziò a Stanford; con il fisico Gerald O’Neill della Princeton University (New Jersey), egli contribuì a costruire la prima coppia di anelli al mondo per conservare gli elettroni. Lo SPEAR fu il successivo progetto, con elettroni e positroni tenuti in un singolo anello, e il progetto “Positron-Electron” (PEP), un anello di accumulo di energia più elevata, allo SLAC nel 1980.
Richter cercava di raggiungere energie di particelle sempre più elevate. Per produrre molte particelle Z, portatrici della forza nucleare debole, inventò il collider lineare. Brevi impulsi di elettroni e positroni ad alta energia, in fasci della larghezza di un capello umano, viaggiano per chilometri e chilometri lungo l’acceleratore in percorsi separati e poi si scontrano, producendo occasionalmente particelle Z. Il collider ha prodotto, tra i vari importanti risultati, uno stretto limite superiore sulla massa del bosone di Higgs e ha dimostrato la fattibilità del concetto di “collider lineare” per le macchine del futuro. Per ottenere collisioni con energia ancora più alta, egli sostenne la creazione di due acceleratori lineari testa a testa, ma una macchina del genere deve ancora essere costruita.

Egli intuì anche che lo SLAC doveva diversificarsi per sopravvivere. Quando lo SPEAR era in costruzione, i fisici della materia condensata Sebastian Doniach e William Spicer della Stanford University, lo convinsero ad aggiungere una piccola finestra nel tubo a vuoto dell’anello di accumulazione delle particelle, in modo che i raggi X prodotti dagli elettroni o positroni circolanti potessero uscire. Ciò ha creato la fonte di raggi X più intensa allora disponibile, aprendo la porta alla scienza dei raggi X. Gli intensi impulsi dei raggi X hanno molte applicazioni nella scienza dei materiali, nella chimica e nella decifrazione delle strutture biologiche. Attualmente è uno degli usi principali dello SLAC. Egli ha anche portato l’astrofisica delle particelle in laboratorio e ha supportato un piano per convertire l’acceleratore SLAC nel primo laser al mondo a raggi X (con impulsi di raggi X ancora più intensi).
Nel corso degli anni ha servito la comunità anche in altri modi; fu un membro del gruppo JASON (che forniva consulenza tecnica al governo degli Stati Uniti), lavorò in innumerevoli panel scientifici e consultivi nazionali e internazionali, fu consigliere e presidente della American Physical Society.
Si preoccupava più delle idee che non del riconoscimento; condivideva le sue intuizioni tecniche e il suo acume con chiunque per migliorare gli esperimenti. Se un postdoc o uno studente aveva una buona idea, egli lo supportava; analogalmente, se era in disaccordo con uno scienziato di alto livello, chiariva il problema senza particolari riguardi. Ha dato responsabilità a coloro che ha trovato più capaci, senza riguardo all’anzianità o alla fama. Amava fare fisica, costruire esperimenti in grado di raggiungere le più alte frontiere e cercare di oltrepassarle (vedasi anche: Nature, vol. 560 (Agosto 2018)).
Paolo Di Sia
Paolo Di Sia è attualmente professore aggiunto presso l’università degli studi di Padova e l’università degli studi di Bolzano. Ha conseguito una laurea (bachelor) in metafisica, una laurea (master) in fisica teorica, un dottorato di ricerca in fisica teorica applicata alle nano-bio-tecnologie e un dottorato di ricerca in matematica “honoris causa”. Si interessa del rapporto tra filosofia e scienza, di fisica alla scala di Planck, di nanofisica classica e quantistico-relativistica, di nano-neuroscienza, di fisica transdisciplinare e di divulgazione scientifica. È autore di 276 lavori distribuiti tra riviste nazionali e internazionali, capitoli di libri, libri, interventi accademici su web scientifici, pubblicazioni accademiche interne, lavori in stampa. È reviewer di vari international journals, membro di molte società scientifiche internazionali e international advisory/editorial boards, gli sono stati attribuiti vari riconoscimenti internazionali.
Paolo Di Sia
Università di Padova (Italy) & Libera Università di Bolzano (Italy)
E-mail: paolo.disia@libero.it
Webpage: www.paolodisia.com





























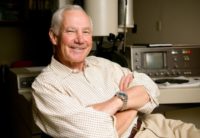










Commenti
Vite di persone di scienza: Burton Richter — Nessun commento